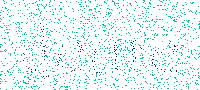
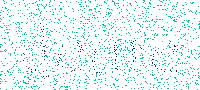
INTRODUZIONE
Comprendere l'organizzazione del sistema scolastico del Giappone contemporaneo è possibile solo facendo ricorso ad un'immagine strutturale del complesso della società giapponese. L'analisi e la comprensione del comportamento individuale e delle relazioni interpersonali è, nella società giapponese, indispensabile per la decifrazione sia dell'organizzazione del gruppo sia delle tendenze strutturali che determinano lo sviluppo della società stessa.
In questa prospettiva risulta evidente il fatto che, sotto molti punti di vista, la complessa struttura della società tradizionale giapponese sembra persistere nonostante i grandi mutamenti intervenuti nel corso dell'ultimo secolo.
Buona parte degli studi sociologici sul Giappone contemporaneo insiste sulla trasformazione sociale, sulla presenza di una conflittualità evidente tra aspetti tradizionali e moderni della società. Secondo questa prospettiva di indagine, ogni fenomeno tipico della società giapponese e non riscontrabile in quelle occidentali dovrebbe per ciò stesso essere etichettato come feudale, tradizionale, premoderno. Come tale esso andrebbe interpretato come contrastante con la modernità e ostacolo alla modernizzazione. E' evidente che questa lettura del Giappone contemporaneo tende a ricondurre il percorso dello sviluppo sociale giapponese ad una replica pura e semplice delle dinamiche di sviluppo delle società occidentali, cui viene contrapposta la persistenza di alcuni aspetti arcaici, premoderni, destinati ad essere abbandonati con l'avanzare della modernizzazione.
Il tessuto della società giapponese viene sostanzialmente tagliato in due da questo tipo di lettura. Si esclude la possibilità che esso abbia invece un carattere organico e fortemente integrato, nel quale aspetti tradizionali e tratti di modernità convivono ed interagiscono generando una struttura unica, irriducibile alle forme della modernità e dello sviluppo dei Paesi occidentali.
Tra i vari aspetti tradizionali persistenti nel tessuto sociale giapponese mi pare che quello più significativo per la ricostruzione della struttura del sistema scolastico giapponese e per l'interpretazione del significato che esso svolge nel contesto della società nipponica sia rappresentato dal principio di verticalità. L'aspetto probabilmente più caratteristico dell'organizzazione sociale giapponese e' rappresentato dalla presenza di un singolo legame nei rapporti sociali: individui o gruppi di individui hanno sempre un solo rapporto con gli altri. Il quadro di organizzazione sociale che deriva dal prevalere di questo tipo di rapporti interpersonali e tra gruppi è quello di una società stratificata non già orizzontalmente per classi o per caste, bensì verticalmente, per istituzioni o gruppi di istituzioni. Evidentemente anche nel Giappone contemporaneo esistono classi sociali più o meno analoghe a quelle delle società occidentali; il fatto è però che questa stratificazione orizzontale non ha nella società alcuna possibilità di funzionare come principio di organizzazione e non riflette la reale struttura sociale del Paese. Lo scontro sociale non passa in Giappone attraverso fratture verticali, bensì' attraverso il confronto di gruppi o organizzazioni che si fronteggiano fianco a fianco, da posizioni parallele. La competizione ha cioè luogo tra gruppi paralleli e, di conseguenza, la conflittualità tra lavoratori e direzione assume, quando esiste, la forma di un affare di famiglia, non così essenziale nella strutturazione delle relazioni sociali.
Una competizione sociale che ha luogo tra gruppi paralleli dello stesso tipo (contrapposti per il fatto di costituire famiglie diverse, alternative) fa si che il nemico vada sempre cercato tra coloro che appartengono alla stessa categoria (operai dell'azienda x contro operai del gruppo y, e lo stesso dicasi per i quadri dirigenti), mentre in Occidente questi stessi gruppi sarebbero legati da vincoli di solidarietà e da basi programmatiche comuni.
Questa struttura dei rapporti sociali non è tipica esclusivamente del mondo della produzione; il sistema scolastico, tanto a livello universitario quanto di scuola dell'obbligo, è governato dal medesimo tipo di dinamiche: università contro università, liceo contro liceo, scuole di città contro scuole rurali, ecc..
Questa dinamica produce sul funzionamento della società due tipi di effetti molto diversi: da un lato un effetto di coesione, di compattamento, di concentrazione di tutte le energie disponibili verso gli obiettivi del gruppo (inteso come ditta, scuola o società nel suo complesso). Dall'altro, determina una serie di fratture verticali all'interno della società che si traducono in competitività accentuata tra gruppi ed istituzioni. L'esperienza lavorativa e scolastica del giapponese, segnate da una costante competizione in termini accentuatamente pragmatici, ruotano stabilmente attorno ad un problema: qual è la mia posizione in classifica?. La lotta per occupare una posizione più elevata nella gerarchia sociale ha una grandissima importanza nella vita delle persone.
Tutto ciò è senza dubbio un lascito dell'organizzazione sociale arcaica del Giappone (i sociologi ne fanno risalire l'origine al sistema che regolava la gerarchia delle famiglie nelle comunità di villaggio del Giappone del passato). E' evidente però quanto del prestigio e della competitività di cui l'economia giapponese gode oggi in ambito internazionale si giochi su questo carattere peculiare dell'organizzazione sociale giapponese. Siamo allora, in questo caso, di fronte ad un aspetto tradizionale o moderno? E' evidente che il problema non può essere posto in questi termini semplificati e, in effetti, la tradizione mostra di sopravvivere nella modernità e di saperne divenire un fattore strutturante.
Un altro aspetto di grande interesse è rappresentato dai meccanismi che regolano la compilazione di queste graduatorie di status sociale e la loro periodica revisione. Anche in questo caso la tradizione sopravvive nella modernità' e si coniuga con essa. Cosi' come nelle comunità di villaggio le famiglie occupavano una posizione tanto più elevata nella gerarchia sociale quanto più antico era stato il loro insediamento nel villaggio e la ricchezza costituiva solo un fattore addizionale nella compilazione della graduatoria, così oggi nel Giappone contemporaneo il prestigio sociale dipende non tanto dal denaro che si possiede quanto dal gruppo al quale si appartiene e dalle relazioni personali che ci legano a qualcuno.
Il bisogno di competere con successo genera però anche un'altra caratteristica peculiare delle istituzioni: l'uniformità, la conformità ad un modello che ne renda le prestazioni confrontabili con quelle delle istituzioni che hanno interessi e attività sovrapponibili. Ogni istituzione cerca di imitare il modello della concorrente che occupa la posizione di vertice nella gerarchia, ne imita i modelli organizzativi ed operativi. E' evidente come, se da un lato questo meccanismo spinge ad una competizione esasperata, dall'altro genera sul piano della produzione industriale un elemento di debolezza estrema del sistema, l'uniformità, il carattere anonimo del prodotto (quindi una ridotta identificabilità commerciale del prodotto della singola impresa e, più in generale, del prodotto giapponese); sul piano scolastico, la mancanza di individualizzazione nell'insegnamento, la mortificazione della professionalità degli stessi docenti.
Queste caratteristiche della società giapponese finiscono, in ultima istanza, con il contribuire al rafforzamento dell'organizzazione politica statale e all'intensificazione del controllo di questa sulla società civile. I gruppi in competizione costante, vedono fortemente ridotta la propria capacita' di trattare con autorevolezza con l'amministrazione statale. Ostilità e rivalità che dividono i gruppi, favoriscono l'accettazione dell'egemonia dello Stato. Inoltre, proprio perché ogni gruppo è organizzato gerarchicamente al proprio interno, esso favorisce la trasmissione dell'autorità amministrativa statale dall'alto al basso attraverso l'organizzazione interna del gruppo stesso.
Tutto ciò evidenzia come il sistema politico e sociale del Giappone moderno abbia ereditato i propri elementi fondamentali dal precedente periodo Tokugawa, e come le stesse trasformazioni intervenute nel periodo Meiji, in apparenza radicali, non abbiano determinato in realtà modificazioni strutturali dei caratteri di fondo dello Stato e dei rapporti di base della società.
Un sistema sociale, inoltre, che premia l'istituzione, il gruppo, il sistema società nel suo complesso, più che non la qualità individuale ed il singolo nella sua autonomia individuale.
Per quanto riguarda le scuole, la gerarchia in base alla quale esse vengono classificate sembra riflettere quella delle antiche famiglie: una scuola e' più importante e prestigiosa se e' di più antica istituzione; a questo criterio si affianca quello della valutazione dei piazzamenti annuali ottenuti dai suoi studenti negli esami di ammissione ai corsi di livello superiore. Una ditta o una scuola cui sia stata riconosciuta una certa posizione di rango, tenderà a mantenerla per un certo tempo anche se i suoi risultati sono meno brillanti di quelli ottenuti da altre istituzioni classificati ad un livello inferiore. Un'azienda o una scuola che i Giapponesi collocano ai vertici della gerarchia non e' necessariamente quella che negli anni precedenti ha ottenuti i maggiori profitti o i migliori risultati.
Che il problema sia di grande rilievo per i Giapponesi e' confermato dalla lingua. Esistono infatti espressioni specifiche per definire queste istituzioni di vertice: ichi-ryu-gaisha è la società al vertice; ichi-ryu-ko è la scuola più prestigiosa. Il significato di ichi-ryu e' letteralmente sopra tutto, ideale, prima classe, ed e' interessare notare che le istituzioni classificate ni-ryu (seconda classe) e san-ryu (terza classe) non costituiscono vere categorie indipendenti, ma sono piuttosto tutte quelle non comprese in ichi-ryu. Le istituzioni di seconda e terza classe sono costantemente in lotta per divenire ichi-ryu, e questa spinta sociale sembra essere più determinante della stessa volontà di conseguire maggiori profitti per le aziende o di offrire migliore formazione ai propri studenti per le scuole.
Si può dire quindi che i Giapponesi paiono orientati più verso valori sociologici che non verso obiettivi economici! Il loro status sociale, il prestigio e la considerazione di cui godono dipendono infatti dall'appartenenza ad una istituzione, molto meno dal contesto sociale di provenienza. Il fattore decisivo del successo è rappresentato dall'opportunità di entrare in un certo gruppo o, che è la stessa cosa, di legarsi ad una certa persona. Ai fini della collocazione sociale degli individui, l'ordine gerarchico secondo il quale si distribuiscono socialmente gruppi e istituzioni svolge una funzione analoga a quella della classificazione per classi o per caste. Poco interessati alle differenze di classe, i Giapponesi concentrano la propria attenzione sulla posizione gerarchica e sui vicini immediati. Saper costruire forti legami personali in una fase precoce della propria vita è (ed è sempre stato) decisivo per l'uomo giapponese. Le proprie ambizioni sono legate al kobun, frequentemente considerato più importante degli stessi figli o dei parenti.
Ciò favorisce, evidentemente, una forma interessante, strana per gli occidentali, di mobilità sociale, ed il sistema scolastico del Giappone attuale contribuisce in modo significativo a questo tipo di mobilità. Frequentare una buona scuola, accedere ad una università prestigiosa e' un passaggio fondamentale per la mobilità verso l'alto dell'individuo. La società giapponese considera la carriera scolastica come uno dei criteri essenziali per la valutazione delle capacità e quindi delle possibilità di affermazione sociale di un individuo. Le capacità individuali vengono immediatamente tradotte (e non possono non esserlo) in termini di curriculum scolastico, di prestigio della scuola frequentata, di status assunto dallo studente all'interno della comunità scolastica di appartenenza. I titoli di studio sono considerati elementi indiscutibili per la valutazione del valore di un candidato, hanno validità oggettiva, indiscutibile, condivisa. Ne consegue un investimento esasperato da parte delle scuole giapponesi sui metodi e gli strumenti di valutazione, rigidamente istituzionalizzati ed uniformati. Poca o nulla attenzione viene ovviamente invece riservata, tanto nella valutazione scolastica quanto nella carriera lavorativa alle esperienze personali; ciò proprio perché esse non sono misurabili, valutabili in modo oggettivo ed istituzionalizzato (il che non favorisce certo percorsi di accrescimento professionale individuali, esperienze di studio o di lavoro all'estero, ecc.).
Non solo però durata e qualità degli studi costituiscono fattori decisivi di affermazione sociale; anche l'aver frequentato una scuola prestigiosa, collocata in una posizione alta della gerarchia socialmente riconosciuta, costituisce un buon passaporto per il proprio futuro. Ciò favorisce evidentemente il costituirsi di una gerarchia tra le scuole (con effetti molto più evidenti e problematici a livello universitario, ove più forti sono le pressioni del mondo del lavoro), e il definirsi di utenze esasperatamente omogenee per i singoli istituti. L'effetto finale di questa dinamica è quindi anche la formazione di scuole d'elite e, per converso, di scuole ghetto ove si riversano i problemi di un'utenza che non ha e non avrà possibilità di affermazione sociale attraverso gli studi. Il rango dell'università nella quale ci si è laureati determinerà, in modo più o meno automatico, l'accesso ad una certa posizione sociale o il successo che ci si potrà aspettare nella vita. La possibilità poi di accedere ad una buona università è legata alla provenienza da un'ottima scuola secondaria, e così, a ritroso, sino alla scuola elementare. Il sistema scolastico giapponese comporta così un altissimo tasso di competitività, assolutamente non paragonabile a quello presente in altri sistemi, e ciò spiega il livello di stress che caratterizza gli studenti giapponesi e l'alto livello di disagio e di episodi di devianza (violenza diffusa, suicidi, ecc.) evidenziato dalle statistiche.
Non si possono infine ignorare gli effetti di ricaduta che questa situazione produce sui docenti, tanto da un punto di vista professionale (classi ingestibili, violenza diffusa, ecc.) quanto da un punto di vista psicologico (frustrazione, depressione, ecc.). Nè si possono ignorare i costi, economici ed umani, per le famiglie di questo sistema che le obbliga a fare l'impossibile per garantire ai propri figli l'accesso ad una delle scuole-fabbriche che potranno pilotarlo verso una carriera prestigiosa ed il successo sociale.
In termini sociologici, il sistema sociale giapponese è quindi un sistema segmentario. Tuttavia, per le varie imprese individuali che costituiscono il gruppo non è importante il riconoscimento dell'intero sistema, bensì il legame tra due soggetti (X, dal quale giungono all'istituzione informazioni e ordini; Y, al quale l'istituzione invia informazioni e ordini). Il carattere specifico di questo sistema segmentario è quindi quello di non costituire il nucleo della formazione di un gruppo, bensì il risultato di un accumulo di singoli legami tra due istituzioni e della loro progressiva espansione.
Merita di essere sottolineato come questi rapporti tra istituzioni (anche nel caso delle imprese industriali moderne) risultino nella sostanza identici a quelli che legavano nel Giappone rurale le famiglie di agricoltori secondo vincoli tra proprietario e fittavolo. Lo stesso termine usato per designare questo tipo di relazioni, oyako, letteralmente genitore-figlio, ben definisce quella che ancora oggi è una delle aspirazioni più alte per ogni giapponese: il desiderio di essere amato da qualcuno, il desiderio di dipendenza (espresso dal termine amae, dal verbo amaeru, giocare ad essere bambino). Si tratta di un rapporto che attraversa tutta la vita del giapponese medio, dal grembo materno, al rapporto madre-figlio, marito-moglie, lavoratore-datore di lavoro, allievo-insegnante, seguace-leader. Desiderare di essere amati da qualcuno significa, in realtà, voler godere della gentilezza degli altri e offrire loro l'opportunità di concedere sostegno dimostrando attenzione e cura. Comprendere il concetto di amae significa capire molto del Giappone e avere la possibilità di comprendere il significato di altri concetti, come quello di on-giri. On-giri è uno dei fondamenti della società giapponese: il concetto di on, derivato dalla filosofia cinese e dalla società feudale giapponese, esprime un obbligo morale, il peso della gratitudine (in senso sociale e psicologico) che chi ha ricevuto un favore o un dono da parte di un superiore gli deve. On è quindi il peso della gratitudine dovuta a tutti coloro cui siamo verticalmente legati e dai quali dipende la nostra riuscita nella vita, quindi gli antenati, i genitori, gli insegnanti, i superiori sul lavoro. La struttura dell'intera società giapponese si regge su questo valore, che obbliga chi sta sopra a mantenere un atteggiamento di paterna tutela nei confronti dei subordinati, e a questi di dimostrare rispetto, riconoscenza e lealtà a quelli. On è poi così profondo che non si potrà mai ripagare completamente, il che fa si che chi lo riceve si trovi in una posizione di perenne subordinazione a chi lo offre.
Dal concetto di on deriva direttamente quello di giri. Giri è l'obbligo di agire secondo le regole sociali, favorendo chi ha favorito, aiutando chi ha aiutato. Obbligo che assume, a volte, caratteri puramente formali e simbolici (come nel caso della vera e propria mania dei Giapponesi per i regali), altre volte l'aspetto di una regola estremamente radicata nella struttura sociale, dalla quale può dipendere in senso vero il successo di una persona (come confermato, del resto, dal fatto che l'espressione on shirazu, usata per definire chi non la rispetta, letteralmente "colui che non conosce on", e' uno dei peggiori insulti che si possa rivolgere ad un giapponese).
Attraverso questi concetti è possibile capire l'abilità dei Giapponesi a fondersi con il gruppo (in senso proprio l'individuo esiste in Giappone solo come parte del gruppo), il carattere poco sviluppato del senso di individualià e la quasi assenza del valore della privacy. Amae, un concetto che da un punto di vista occidentale avrebbe poco piacevoli implicazioni freudiane, esprime invece in Giappone un valore positivo: il sospetto per ogni persona che sia o aspiri ad essere totalmente indipendente (perché arrogante e poco sociale) e l'esaltazione dello spirito di gruppo e della solidarietà tra i costituenti di una stessa struttura. Fragilità dell'individuo (che dipende sempre da altri) quindi, ma anche creazione di rapporti profondi e solidi di collaborazione ad ogni livello dell'organizzazione sociale (la famiglia, la scuola, l'azienda).
Il valore della collaborazione tra i membri del gruppo trova poi la propria espressione più piena nel concetto di nemawashi. Nemawashi è l'arte, praticata in famiglia, a scuola, in azienda, in politica, di costruire il consenso, di prendere decisioni solo dopo aver consultato tutte le opinioni. Una pratica di estrema utilità dal punto di vista sociale: garanzia di costante armonia, essa fa si che nessuno si esponga singolarmente in modo eccessivo e che le decisioni, una volta prese, non siano più contestate e vengano rapidamente attuate (del resto, è molto interessante la stessa origine contadina del termine che stava tradizionalmente ad indicare "l'atto di scavare intorno alla radice di un grande albero uno o due anni prima del trapianto, recidendo tutte le radici eccetto la principale e le grandi radici laterali, e consentendo la crescita di nuove, facilitando così il trapianto e permettendo in tal modo anche all'albero di produrre migliori frutti").
Tutti questi valori trovano probabilmente la loro composizione più piena nel concetto, davvero fondamentale nella società giapponese, di wa. Wa è il corrispondente giapponese di un ideogramma cinese impiegato originariamente per designare il Giappone e i sui abitanti. Con il tempo esso passo' a designare l'armonia, l'unita', l'ordine, la concordia, la capacità di un essere umano di integrarsi armonicamente con ciò che lo circonda. Wa è valore etico e sociale al tempo stesso capace di garantire ordine e pace per il singolo e la collettività, nonché la capacità di integrare le proprie forze per la felicità del gruppo; è il funzionamento armonico del gruppo cui bisogna saper sacrificare, se necessario, se stessi. Wa è qualcosa per cui bisogna battersi, qualcosa che non si dà per scontato e garantito. Wa non implica uguaglianza, bensì ordine, suddivisione di ruoli che ognuno, singolo o gruppo, deve rispettare perché il giusto ordine del mondo possa essere mantenuto, unità armoniosa dell'uomo con la natura e l'universo.
Tutti i più importanti comportamenti sociali dei giapponesi (l'inchino,
la cerimonia del tè, l'ikebana, l'armonia del giardino giapponese,
ecc.), rientrano nel concetto di wa. La società giapponese
attribuisce grande importanza all'armonia nelle relazioni con ciò
che ci circonda (la natura, la società, gli altri), il che fa della
capacità di cooperare con gli altri e del saper far parte di un
gruppo unito e funzionale un'esperienza naturale e soddisfacente per l'uomo
giapponese. La scuola stessa riflette pienamente questo valore: la partecipazione
alla vita scolastica nei suoi aspetti sociali, la capacità di assumere
responsabilità nella comunità, sono incentivati dall'istituzione
e sentiti fortemente dai singoli
CENNI STORICI SUL SISTEMA SCOLASTICO GIAPPONESE
Durante il periodo Edo (prima del 1868), l'istruzione scolastica era in Giappone riservata a determinate classi sociali e differenziata per gruppi. Essenzialmente chi poteva garantire ai propri figli un'istruzione erano i signori feudali, interessati alla formazione militare dei propri discendenti, i mercanti ed i contadini la cui istruzione era orientata essenzialmente alla formazione di abilità tecniche e competenze professionali.
Nel 1872 viene creato il sistema scolastico nazionale moderno in Giappone e nel 1886 viene introdotta per la prima volta l'obbligatorietà della istruzione primaria (4 anni). Il tasso di scolarizzazione cresce molto rapidamente nel Giappone investito dal primo processo di modernizzazione economica per effetto di questi provvedimenti, tanto che già nel 1905 l'obbligo scolastico è assolto dal 95.6% della popolazione, mentre il 20% c.ca riceve già un'istruzione secondaria.
Un secondo passaggio importante del sistema scolastico giapponese è rappresentato dal secondo dopoguerra e dal profondo processo di trasformazione imposto dalla sconfitta bellica e dal ruolo giocato dagli Stati Uniti. La nuova costituzione giapponese stabilisce all'art. 26 che "tutti hanno diritto ad eque opportunità formative in rapporto alle proprie abilità. L'istruzione è obbligatoria per tutti i maschi e le femmine per 9 anni ed i genitori ne hanno la responsabilità. Tale periodo di istruzione obbligatoria è gratuito".
Nel 1947 la legge n. 25 (Foundamental Law of Education) fissa alcuni principi importanti:
Nel 1948 viene istituito il sistema delle scuole secondarie superiori con corsi a tempo pieno e part time (cui verranno aggiunti nel 1961 i corsi per corrispondenza).
Nel 1949 viene promulgata la legge di riforma del sistema universitario.
Nel 1950 viene avviato, su basi sperimentali, il sistema delle lauree brevi (a regime dal 1964).
Nel 1962 vengono istituiti i Colleges of Technology, diplomi
di laurea, originariamente previsti solo per ingegneria e marina mercantile,
della durata di cinque anni e riservati ai diplomati delle scuole secondarie
inferiori.
I PROBLEMI APERTI DELLA SCUOLA GIAPPONESE ODIERNA
Le trasformazioni profonde e rapide degli anni recenti hanno senza dubbio contribuito ad aprire una serie di fratture nel sistema educativo giapponese, con effetti particolarmente visibili e temibili nel sistema scolastico. L'apertura dell'economia e della società giapponese (peraltro ancora limitata) ad altre realtà mondiali, l'aumento della propensione dei giapponesi a viaggiare all'estero per ragioni diverse (di lavoro, d'affari, di studio, di svago), il diffondersi di modelli valoriali e comportamentali di derivazione occidentale, hanno evidenziato contraddizioni profonde:
I consigli scolastici locali, i centri polivalenti, gli uffici della Prefettura e del Municipio, ecc. organizzano corsi, lezioni, programmi culturali e sportivi, nella maggior parte destinati alla formazione permanente degli adulti.
Va sottolineato inoltre come, proprio per rispondere a questa domanda
di formazione, le autorità pubbliche giapponesi abbiano avviato
negli ultimi anni un poderoso programma per la costruzione di infrastrutture
e per la promozione di nuovi modelli formativi (istruzione a distanza,
educazione degli adulti, autoapprendimento, ecc.).
ASILI NIDO (prepar. scuola mat) da 0 a 5 anni
SCUOLA MATERNA (3 anni) da 3 a 6 anni
SCUOLA ELEMENTARE (6 anni) da 6 a 12 anni
S.SEC INFERIORE (3 anni) da 12 a 15 anni
S. SEC. SUPERIORE (3 o più) da 15 a 18-19 anni
JUNIOR COLLEGE (2 o 3 anni, di solito due)
SCUOLE PROFESSIONALI (accesso con S.Sec.Inf. - poco diffuse)
UNIVERSITA' (da 4 a 6 anni)
CORSI POST-LAUREA (2 anni)
DOTTORATO (3 anni)
Negli ultimi anni si è affermata la tendenza ad offrire agli studenti corsi di studio focalizzati su aree specifiche o, addirittura, su singole discipline. Ciò allo scopo di rispondere in modo forte ai bisogni formativi dell'utenza ed a specifiche esigenze emergenti dal contesto socio-economico.
Ogni scuola ha quindi oggi la libertà, entro una cornice generale stabilita dal Monbusho, di organizzare corsi a propria discrezione.
Un'altra tendenza attuale della scuola giapponese riguarda la diffusione delle comprehensive schools. Si tratta di corsi che, nati a partire dal 1994 dalla riorganizzazione dei preesistenti corsi generali o speciali, offrono allo studente un'ampia gamma di discipline tra le quali poter scegliere per poter comporre un proprio, unico, piano di studi individuale.
La scuola secondaria superiore è organizzata , a partire dal
1988 per i corsi diurni e serali e dal 1993 per i corsi a tempo pieno,
secondo il sistema dei crediti formativi. Indipendentemente
dal numero di anni di corso, il conseguimento del diploma viene legato
in questo sistema ad un certo numero di crediti formativi che devono essere
conseguiti. Non esiste quindi promozione da un grado all'altro.
Esistono oggi tre tipi di curriculum nella scuola secondaria superiore giapponese: corsi generali, corsi speciali (vd. lucido per tipologie) e corsi comprehensive (istituiti dal 1994 e caratterizzati dalla presenza contemporanea degli orientamenti generale e speciale attraverso la moltiplicazione delle materie elettive.
I curricula vengono stabiliti dal Monbusho e sono stati riformati per l'ultima volta nel 1989. I nuovi corsi sono stati introdotti a partire dal 1994.
Il rilascio del titolo di studio è legato al conseguimento di un minimo di 80 crediti formativi. Ogni credito corrisponde a 35 ore di lezione per anno scolastico (i moduli orari corrispondono a 50 minuti).
I crediti formativi vengono distinti in: obbligatori (per tutti
gli studenti e per qualsiasi corso di studio), elettivi e special
activities (ogni istituto è tenuto ad offrire almeno due ore
settimanali per le attività dei club studenteschi, per gli eventi
scolastici e per home - room activities.
Per le scuole materne il numero massimo di studenti previsto per classe è di 40. Il numero medio di studenti per classe nell'anno 1992 era di 26.4.
Per le scuole elementari e secondarie inferiori pubbliche il numero massimo di alunni per classe è fissato dai consigli scolastici locali. Questo numero non può comunque superare il massimo stabilito dalla legge nazionale che e' di 40 alunni per classe (45 sino al 1980).
Per le scuole secondarie superiori il numero massimo di alunni per classe fissato dalla legge nazionale è di 40.
Non esistono in Giappone norme che colleghino il numero di studenti
per classe ad una superficie minima. Esistono invece leggi che identificano
le superfici minime per scuole elementari, medie inferiori e superiori
di 18 classi (considerata dimensione standard per una scuola).
La tabella mostra la distribuzione per sesso del corpo docenti nella scuola giapponese. Si possono notare essenzialmente due particolarità:
La selezione degli studenti candidati all'ammissione si basa sulla valutazione dei seguenti elementi: raccomandazione da parte del preside della scuola secondaria inferiore, esito del test di selezione, altri crediti (per attività sportive, culturali, di volontariato, ecc.).
Nelle scuole pubbliche, i test di ammissione sono condotte dalle singole scuole sotto la supervisione delle rispettive autorità scolastiche (della prefettura o del municipio) che fissano modalità e standard.
Le scuole private conducono le selezioni autonomamente, seguendo però le modalità stabilite dalle leggi vigenti.
Ogni aspirante si deve candidare, in linea generale, alla scuola del bacino di utenza al quale appartiene. Ciò allo scopo di favorire a tutti eguali opportunità di accesso alla scuola sec. superiore.
La diversificazione dei corsi di studio intervenuta negli ultimi anni e la necessità di rispondere alle nuove esigenze formative degli studenti, ha spinto il Monbusho ad assumere le seguenti iniziative:
L'anno scolastico ha inizio il 1 Aprile e termina il 31 Marzo
La maggior parte delle scuole adotta una suddivisione delle attività scolastiche in tre periodi: da Aprile a Luglio, da Settembre a Dicembre, da Gennaio a Marzo
Le vacanze scolastiche prevedono: 13 festività nazionali stabilite per legge, alcuni sabati (generalmente il secondo sabato del mese) durante l'anno e tre periodi di interruzione delle attività didattiche (c.ca 40 gg. in estate, c.ca 15 gg. in Dicembre, c.ca 10 gg. tra Marzo e Aprile), la cui durata e la cui esatta collocazione vengono stabilite dalle autorità locali e variano quindi da zona a zona.
Le scuole private stabiliscono autonomamente, in accordo con la normativa vigente, i periodi di vacanza.
A partire dal 1992 è stata introdotta in forma sperimentale la
possibilità della settimana corta. Inizialmente questa possibilità
è stata prevista per una sola settimana al mese (in genere la seconda),
ma è ora in atto un tentativo, peraltro osteggiato soprattutto dalle
famiglie, di estendere questa modalità all'intero arco mensile delle
attività.
Per ogni grado scolastico esistono tre tipi di certificato di abilitazione: regolare, speciale, temporaneo.
Certificato regolare: è rilasciato agli insegnanti di ruolo; è valido in tutte le prefetture del Paese; è differenziato a seconda del soggetto di insegnamento per le scuole secondarie inferiori e superiori, mentre per le scuole materne e primarie l'abilitazione consente di insegnare tutte le discipline; i certificati regolari sono poi differenziati in tre categorie:
Certificato speciale: è rilasciato a quegli insegnanti che hanno competenze speciali; viene conferito dalle prefetture (ed ha validità solo nella prefettura che lo ha rilasciato) ed ha una validità di non più di dieci anni;
Certificato temporaneo: viene rilasciato dalle prefetture in caso di carenze di organico ed ha validità massima, entro la prefettura, di tre anni; conferisce il titolo di assistant teacher.
Nella scuola secondaria superiore, circa il 96% degli insegnanti è
attualmente in possesso di un First class Certificate; nella
scuola sec. inferiore, c.ca l'87% dei docenti è attualmente in possesso
di un First class Certificate.
Nelle tabelle 3 e 4, il quarto livello si riferisce ai capi d'istituto, il terzo ai vice-presidi, il secondo agli insegnanti ed il primo agli assistant teachers.
Tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche hanno diritto a 30 giorni annui di ferie pagate al 100%.
L'assenza per malattia prevede una retribuzione piena per i primi 90 giorni e quindi una riduzione del salario al 50% per i periodi successivi. Gli insegnanti affetti da tubercolosi hanno diritto ad un periodo di congedo speciale di due anni con salario garantito al 100%.
L'assenza per maternità è di 14 settimane a salario intero, mentre per l'assistenza ai figli è prevista una riduzione dello stipendio al 30%.