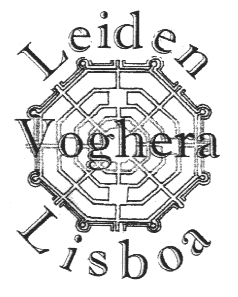
|
Liceo Statale "G.Galilei" - VogheraPROGETTO EDUCATIVO EUROPEOCOMENIUS AZIONE 1QUALE CITTA' PER L'UOMO |
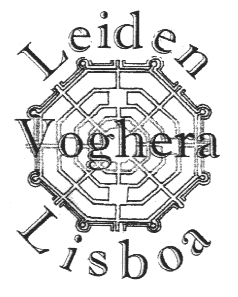
|
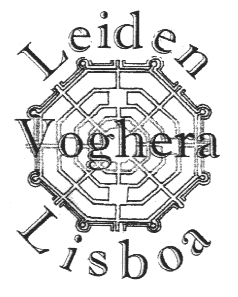
|
Liceo Statale "G.Galilei" - VogheraPROGETTO EDUCATIVO EUROPEOCOMENIUS AZIONE 1QUALE CITTA' PER L'UOMO |
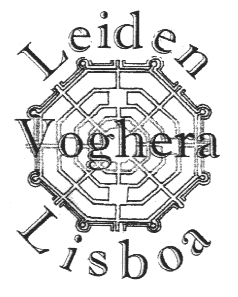
|
INTRODUZIONE
Il problema del rapporto tra la città e la campagna comincia ad essere affrontato in ambito letterario nel Duecento, quindi con le prime affermazioni del volgare in Italia. Gli scrittori del tempo sono concordi nel dichiarare che le città si sono notevolmente estese, con sensibile aumento della popolazione. Si tratta di un fatto variamente giudicato, da taluni autori ritenuto negativo. A questo proposito basti il parere di Dante, che nel XVI canto del Paradiso (vv. 40-72) addita nell’inurbamento degli abitanti del contado la causa principale della rovina di Firenze, che sappiamo passata, nel corso del Duecento, da 50.000 a 100.000 abitanti.
L’affollamento è dovuto al disgregarsi della società feudale, che determina l’abbandono della campagna per la città sia da parte dei piccoli signori oppressi dai grandi feudatari, sia da parte dei servi che lasciano le proprietà signorili. Questa fuga è inizialmente ben vista dai Comuni che talvolta la favoriscono per indebolire il potere feudale.
Un fenomeno parallelo all’inurbamento è il tentativo, da parte della città, di estendere il proprio dominio sul territorio circostante, soprattutto per la necessità di avere a disposizione un’area produttiva in grado di soddisfare le esigenze alimentari dei cittadini aumentati di numero.
Contestualmente i cittadini arricchitisi investono il proprio denaro nell’acquisto di terreni agricoli, dai quali non intendono ricavare il necessario per il mantenimento loro e della famiglia, come i signori feudali, ma un guadagno il più elevato possibile. In questo modo peggiora sensibilmente la condizione dei lavoratori della terra: nel regime feudale non erano liberi, ma potevano sfruttare le aree incolte e integrare con la caccia le proprie necessità alimentari; ora sono liberi, ma in una condizione di maggiore dipendenza economica, perché i proprietari cittadini, che fanno lavorare la terra per venderne i prodotti, esercitano su di questi un controllo ben più rigoroso. In questa situazione il contadino appare agli occhi dei cittadini una figura infida, sempre disposta ad ingannare il padrone, depositaria di tutti i vizi e un po’ bestiale, viva per secoli nella fantasia popolare e letteraria.
La produzione che verrà analizzata appartiene ad un arco di tempo che va dal primo Quattrocento alla metà del Cinquecento e, pur provenendo da ambienti diversi, è per lo più espressione della cultura cittadina, ad eccezione forse dell’opera di MATAZONE DA CALIGANO sul quale non si sa quasi nulla. Le poche notizie che abbiamo su di lui si ricavano proprio dal testo esaminato, in cui si presenta come un villano cresciuto dai "signori". Non sappiamo se si tratti di un’indicazione attendibile, dal momento che, essendo scopo di Matazone elencare i difetti dei contadini, è possibile che egli stesso si presenti come un villano per rendere ancora più efficace la sua critica, facendola pronunciare da un appartenente alla classe dei contadini. L’opera, che risale all’ultimo Trecento o al primo Quattrocento, appartiene ad un’epoca in cui la società feudale è ormai tramontata, anche se in essa il contadino non è visto in opposizione agli abitanti della città, ma ai "signori". D’altra parte l’animosità che Matazone rivela per chi lavora la terra è quella che di norma caratterizza la satira del villano, tipica espressione della cultura cittadina.
In ordine cronologico seguono i testi appartenenti alla civiltà umanistica, cioè i passi tratti dalla Nencia da Barberino di LORENZO DE’ MEDICI, dalle Stanze per la giostra di ANGELO POLIZIANO e dall’ Arcadia di IACOPO SANNAZARO.
Nel loro insieme queste opere evidenziano l’incapacità degli umanisti di comprendere i reali problemi della campagna. Infatti essi sono esponenti di una cultura non solo cittadina, ma anche raffinata ed idealizzante, volta a trascurare la realtà quotidiana. Nei loro testi troviamo da una parte una rappresentazione idealizzata della campagna (Poliziano, Sannazaro), vista come il locus amoenus che ha le caratteristiche del Paradiso terrestre, dall’altra una bonaria ironia che si esprime in modo evidente nella Nencia del Magnifico, in cui l’autore ironizza sorridente nei confronti del contadino Vallera, a cui mette in bocca un canto d’amore alla maniera stilnovista. Il testo, pur facendo riferimento ad alcuni aspetti del contado, non ci offre nessuna rappresentazione realistica dello stesso.
Caratteristiche diverse presentano le opere esaminate risalenti alla prima metà del Cinquecento: la traduzione di un episodio dell’ Eneide ad opera di ANNIBAL CARO ed alcuni passi di TEOFILO FOLENGO e di ANGELO BEOLCO, dello il RUZANTE. Questi autori sono tutti accomunati dal fatto di essere stati amministratori di vaste proprietà terriere e di avere pertanto conosciuto da vicino la vita dei contadini.
Tale conoscenza si esprime soprattutto nelle opere di Folengo e Ruzante, dove, accanto alla tradizionale immagine del villano mezzo bestia, troviamo passi in cui più realisticamente emergono indicazioni sulla dura vita dei lavoratori della terra. In Ruzante non mancano accenti di umana simpatia.
A proposito di questi autori si può anche osservare che la lingua che essi usano, al di fuori di qualunque tradizione letteraria consolidata – il pavano da parte di Ruzante e il latino maccheronico da parte di Folengo - , può essere espressione dell’ambiguità del loro atteggiamento.
Un discorso a sé va fatto per l’opera del CARO. Trattandosi di una traduzione da Virgilio, essa non può ovviamente fare esplicito riferimento alla vita dei contadini del Cinquecento. Tuttavia l’autore riesce ugualmente ad esprimere il suo atteggiamento nei loro confronti, consistente in una profonda avversione: come emergerà dall’esame del passo considerato, il Caro stravolge completamente lo spirito del testo virgiliano, definendo i contadini "pestis" ed attribuendo al loro operato il carattere di una rivolta.